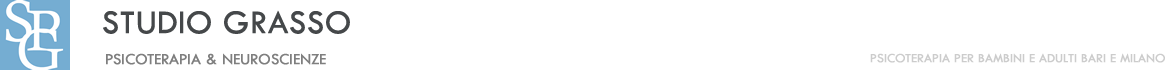Rimango sempre molto colpito dal fatto che in convegni e riviste si continua a discutere della cosiddetta “associazione” o “integrazione” tra farmaci e psicoterapia, come se questo rappresentasse un problema. Ritengo che il vero problema interessante non sia se, come o quando associare farmaci e psicoterapia, ma il fatto stesso che esso venga posto, cioè che vi siano ancora colleghi che sentono l’esigenza di porlo, per cui è in un certo senso di interesse sociologico. già solo il porre questo problema smaschera la errata cultura psicoterapeutica di chi lo pone, una cultura psicoterapeutica che porta a errori tecnici anche nella psicoterapia senza farmaci.
In che senso la psicoterapia e i farmaci sono “cose diverse”?
Il problema della associazione tra psicoterapia e farmaci spesso viene posto nei termini della legittimità o meno di prescrivere farmaci da parte dello psicoterapeuta, in quanto la loro prescrizione si scontrerebbe con la logica della psicoterapia: alcuni terapeuti di ispirazione psicoanalitica, ad esempio, ritengono che se il loro compito è quello di interpretare i significati psicologici dei sintomi o della relazione interpersonale, la somministrazione di farmaci rappresenterebbe un atto incoerente, o un fattore distruttivo della terapia, o un acting out del terapeuta e così via, per cui discutono se farli prescrivere da un altro operatore, o addirittura se non prescriverli affatto. Se questi colleghi sono degli psicoanalisti (e colpisce notare quanti colleghi, anche molto preparati, pongono questo problema), ritengo che essi rivelano una concezione che io definisco squisitamente antipsicoanalitica del fare terapia e del concepire l’analisi dei significati della interazione, e questa errata concezione, come ho detto, non può che ripercuotersi anche sul modo stesso di condurre le stesse terapie senza farmaci, perché riguarda nient’altro che la teoria della tecnica (per la questione della identità della psicoanalisi e della differenza tra psicoanalisi e psicoterapia, che qui è centrale.
Costoro intendono la prescrizione farmacologica come un intervento a parte, come se fosse “somatico” o “biologico”, avulso dagli altri interventi che sarebbero puramente “psicologici”. Quindi gli interventi farmacologici (o i loro effetti) non andrebbero interpretati, capiti, discussi, ma andrebbero solo presi per il loro valore di facciata, mentre solo gli altri interventi sarebbero quelli legittimamente interpretabili, il cui significato cioè potrebbe essere approfondito.
Quello che non è chiaro è con quale criterio il farmaco non dovrebbe appartenere alla stessa categoria logica di tutti gli altri interventi o fatti che accadono nella relazione. La concezione sottostante alla pratica di coloro che ritengono che i farmaci in psicoterapia siano un problema (di qualunque tipo) è quella secondo la quale i significati degli eventi che accadono in terapia (compresi il senso e gli effetti della prescrizione farmacologica) non devono essere scoperti o compresi durante la terapia stessa, ma essi sono già aprioristicamente conosciuti, per cui la terapia non sarebbe altro che un applicare etichette precostituite: ad esempio, l’effetto di un antidepressivo è di un certo tipo, se si prescrive un farmaco ciò significa che il paziente lo vive in un determinato modo a me pregiudizialmente conosciuto (ad esempio come una minaccia alla terapia, mentre invece, alla luce dei sui problemi e del suo modo di vedere le cose, cioè del suo transfert, potrebbe essere esattamente il contrario), e così via…
A livello teorico, il prescrivere farmaci è una operazione identica al non prescriverli, entrambi sono interventi dotati di significato rispetto ad altre variabili. Un paziente senza farmaci, ma che ne ha bisogno perché si suppone che sia privo di una determinata sostanza, riceve lo stesso input “biologico” (se di questo si tratta) di un paziente che li riceve. Il farmaco è un input nell’organismo che, come ogni altro input, ha ogni tipo di effetti, sia “biologici” che “psicologici” (placebo, non placebo, ecc.).
Dovremmo forse rifiutare di analizzare un paziente che ha il brutto vizio di prendere un caffè al mattino? Il caffè è un farmaco con effetti specifici. Dovremmo interpretare la stimolazione psichica da lui ricevuta dal caffè come dovuta al transfert? Solo al transfert? In parte al transfert e in parte al farmaco caffè? Solo al caffè? Ma non sono questi i problemi quotidiani dello psicoanalista? E che dire della donna in tensione premestruale e possibilmente depressa e tesa? E’ influenzata (solo) dal transfert? Essendo affetta da una condizione “organica”, dovremmo allora interrompere subito l’analisi e inviarla ad un medico specialista? E così via.
Paolo Migone.